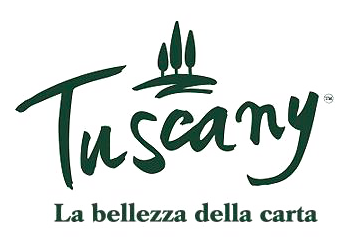Le navi antiche di Pisa
LA STORIA
Nel 1998 iniziarono i lavori lungo la linea ferroviaria Roma-Genova all’altezza della stazione di San Rossore nella periferia di Pisa. Pochi giorni dopo, la fantastica scoperta: a sei metri di profondità emersero uno dopo l’altro un’incredibile serie di relitti navali in eccezionale stato di conservazione, con i loro carichi di prodotti commerciali e le testimonianze della vita a bordo.
Immediatamente gli archeologi si resero conto dell’importanza della scoperta: da allora quello che sapevamo sulla navigazione degli antichi romani è cambiato per sempre.
30 bastimenti tra il II secolo a.C. e il VII d.C., da guerra e da commercio, da mare e da fiume. Undici sono integri. Traghetti, canoe, piroghe, mezzi commerciali, la più grande di 13 metri di lunghezza per 2,5 di larghezza; l’Alchedo, l’unica nave militare dell’epoca conosciuta al mondo e giuntaci quasi intera. In pratica una fotografia collettiva della cantieristica d’età romana di cui prima, effettivamente, non si sapeva molto.

IL CANTIERE
Da quel ritrovamento è nato il Cantiere delle Navi romane di Pisa, che ha restituito circa trenta imbarcazioni di epoca romana e miglia di frammenti ceramici, vetri, metalli, elementi in materiale organico. Si tratta di uno dei più interessanti e ricchi cantieri di scavo e ricerca degli ultimi anni.
I lavori sono durati 20 anni con un investimento di 16 milioni di euro e finalmente, circa un mese, è stato inaugurato il Museo delle Navi di Pisa, il più importante museo di navi antiche del mondo.

LE ALLUVIONI E IL DISSESTO ECOLOGICO: UN NAUFRAGIO LUNGO NOVE SECOLI
Perché tante navi sono state inghiottite per sempre dal fango e detriti? E’ una storia lunga nove secoli. In età etrusca Pisa era una città boschiva che i romani trasformarono in una “città industriale” ante litteram. Strabone ci racconta infatti che Pisa esportava tronchi per costruire le travi delle case, con conseguente disboscamento della valle dell’Arno e del Serchio che portò a un dissesto idrogeologico e lasciò quell’area in balia delle piene fluviali: una ogni 50-60 anni, per quasi un millennio, dicono i dati. Allora l’Arno scorreva poco distante dal luogo (anche la costa era molto più vicina alla città) e nei pressi si trovava il bacino del Serchio. Un posto perfetto per farne una zona portuale molto trafficata, dove stanziavano navi da mare, ma anche piroghe e navi da fiume. Furono realizzati una serie di canali navigabili e tutto questo, sommato al crescente disboscamento fu la causa di alluvioni e tsunami che affondarono per sempre le navi sotto al fango e detriti. L’ambiente umido ha consentito l’eccezionale conservazione dei reperti. Il legno, sott’acqua in assenza di ossigeno, è riuscito a mantenere quasi intatta la sua struttura anatomica.

GLI ARSENALI MEDICEI
Le Navi Antiche di Pisa sono esposte all’interno dei bellissimi Arsenali Medicei, che in origine erano adibiti alla costruzione e alla manutenzione delle galee dei cavalieri di Santo Stefano, il corpo cavalleresco a difesa della minaccia saracena fondato da Cosimo I. Gli arsenali andarono presto in disuso e diventarono prima alloggi militari, poi stalle. Fino alla metà del secolo scorso ospitarono il centro di riproduzione ippica dell’Esercito italiano. Un museo che si estende per 4800 metri quadrati dove il lungo corridoio è la spina dorsale del percorso narrativo: la Pisa di allora, gli eventi che causarono l’affondamento delle navi, le imbarcazioni restaurate e tanto altro.

LO SCAVO
Per la prima volta un restauro di navi è avvenuto in corso di scavo. E’ stato applicato un nuovo protocollo per il restauro del “legno archeologico”, composto in gran parte di acqua che deve essere sostituita da qualcosa di più solido per non deformarsi durante l’asciugatura. Quindi è stato immerso in un bagno di un polimero che, depositatosi sulla parete delle cellule lignee, le ha rinforzate. Poi, ogni singolo reperto è stato avvolto in cellulosa e infornato a 50-60°C perché si indurisse. E’ stato scartato e fatto asciugare molto lentamente per limitare la deformazione e le crepe sono state stuccate e ricoperte di cera naturale.

UNA STORIA DI NAVIGAZIONI, NAUFRAFGI, E VITA DI BORDO
A differenza degli altri musei navali nel mondo a prevalere è l’aspetto narrativo. Oltre ai luoghi sono ricostruite le attività che ruotavano intorno alle navi, le tecniche di navigazione e la vita quotidiana di bordo. Un racconto multimediale attraverso il quale I visitatori non vedono soltanto i singoli oggetti, bensì conoscono le storie di chi era a bordo.

LA POMPEI DEL MARE
Tutti le imbarcazioni sono cariche di vetri, ceramiche, metalli, elementi in materiale organico, oggetti personali di chi viveva a bordo come calzature in legno e una giacca in pelle, fornelli, vasellame, piatti, attrezzi, lucerne, resti vegetali (come semi), utili per capire i commerci e l’alimentazione in mare.
In tutto circa ottomila reperti. Commovente la storia di un’amicizia: lo scheletro di un marinaio abbracciato a quello di un cane, fermati nel tempo da uno tsunami, come accaduto a Pompei a seguito di un’eruzione. Abbiamo anche un’anfora contenente un vino tipo spumante e il bagaglio di un membro dell’equipaggio, una cassetta di legno con alcune monete e medicamenti. E ancora oggetti votivi, piccole statuine delle divinità, scarabei e amuleti (portafortuna per le tempeste). Interessanti i giochi da tavolo e per bambini che venivano usati nel tempo libero.

IL PERCORSO ESPOSITIVO
Il Museo si articola in otto tappe.
I. La città tra i due fiumi
La storia della città di Pisa, il suo sviluppo dagli etruschi, ai romani, ai longobardi
II. Terra e acque
Il rapporto della città con il territorio e l’acqua
III. La furia delle acque
una storia secolare fatta di navi, reperti, storie di vita e di commerci. Approfondimento sul metodo di scavo archeologico in ambiente umido.
IV. Navalia
come si costruivano le navi nel mondo antico e come si costruiscono ora, le moderne tecniche di scavo e recupero e il restauro del legno archeologico.
V. Navi
L’esposizione delle navi e dei loro carichi e corredi suddivisa in due parti: navi da mare aperto e navi da acque interne.
Esposizione dell’Alkedo e sua ricostruzione a grandezza naturale.
VI. Commerci
Diffusione, importazione ed esportazione di merci particolari: beni di lusso, marmi, ceramica fine da tavola.
Tutte le anfore conosciute a Pisa su un’unica parete: forme, contenuti e provenienze.
VII. La navigazione
Le navi romane, a remi e con vele quadre, navigavano regolate da un complesso sistema di manovre; il cantiere ha restituito notevoli parti di vela, che permettono di ricostruire con molta affidabilità il complesso sistema che era alla base della struttura delle vele.
Quanto duravano i viaggi per mare? Quali erano i porti e le rotte più frequentate?
VIII. Vita di bordo
Viaggiare non era molto confortevole, sicuramente come marinaio ma anche come passeggero. Questa sezione descrive i vari aspetti di questa dura vita: l’abbigliamento, i bagagli, le tempeste, l’illuminazione di bordo, come si cucinava e si mangiava, culti e superstizioni, la vita quotidiana a bordo.
Tuscany è un marchio di CARTIERE CARRARA S.p.A. – V.le S. Lavagnini, 41 – 50129 Firenze (FI), Italia – info@www.labellezzadellacarta.it – Privacy